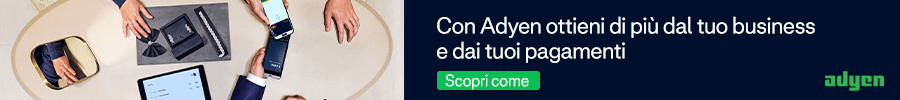Dalla dolce attesa, alla geofagia: viaggio alla scoperta di rimedi e tradizioni legati a fertilità e parto,
con l’Indiana Jones dell’antropologia medica.
In epoca di procreazione assistita, esami prenatali, studi sempre più approfonditi sui meccanismi che governano il benessere dell’apparato riproduttivo femminile e maschile, vedere quanto accade (o accadeva) nel mondo può far sorridere. Ma è comunque importante. Anche perché con una sorta di trasmigrazione culturale nella gravidanza e successiva natalità, si possono scoprire curiosità che la dicono lunga su quanto conoscere il passato che nasce dalla tradizione possa aiutarci ad affrontare una problematica demografica comune a tanti Paesi evoluti. Così, provando ad andare oltre a quelle che sono le dinamiche sociali, economiche e scientifiche che possono impattare sul desiderio di un figlio, proviamo a ripercorrere in un viaggio antropologico costumi e usanze che possono spiegare come è stata vissuta, e magari si viva ancora nella medicina tradizionale, la gravidanza. A guidarci in questo percorso è Antonio Guerci, professore emerito della Cattedra Unesco di Antropologia della salute, biosfera e sistemi di cura e curatore del Museo di Etnomedicina Antonio Scarpa dell’Università di Genova.
Il viaggio, e non poteva essere diversamente, parte dalle migrazioni dello stesso Scarpa, una sorta di Indiana Jones dell’antropologia medica. Pensate. In alcune popolazioni africane alla donna in gravidanza si proponeva la geofagia, ovvero il consumo di pietre eduli ricche di minerali, come forma di integrazione, per favorire il corretto fabbisogno di ferro e calcio. Insomma, la dieta è povera di calcio e le ossa sono fragili? Via libera alla geofagia mirata, ovvero al consumo di pietre eduli ricche di minerali. Il ricorso a questi “integratori” è molto comune in Africa, e non solo per il calcio. “Per combattere l’anemia nell’Africa centrale si consumava l’anyiko, una specie di argilla molto ricca in ferro, di cui si nutrono le donne incinte per compensare proprio quadri anemici gravidici legati alla carenza di ferro – spiega Guerci – Allo stesso scopo in Togo si mangiano i pani cotti al forno a base di glidziblo oppure il calcare (kalaba), che purtroppo si rivela un’arma a doppio taglio, visto che può diventare dannoso ad alte dosi fino a facilitare l’insorgenza di anemia. In Senegal ancora, era usanza consumare durante la gravidanza terre di keu”.
Saltiamo di continente e portiamoci in America Centrale. Perché fertilità e parto sono elementi estremamente significativi nella cultura medica messicana, che già in epoca precolombiana stilizzava queste situazioni in piccole statue. Particolare attenzione veniva prestata, nei secoli scorsi, alle donne che morivano dopo il parto. “Accadeva che le donne morte durante la nascita dell’erede venissero considerate come spiriti, oppure vittime di ‘invasione’ da parte di demoni. Tanto che in alcuni cimiteri era d’uso prevedere una zona separata per le donne decedute per questa causa”. Ma c’è di più. La dolce attesa era considerata una sorta di momento magico. Tanto che si considerava questo aspetto e si arrivava al punto di ‘trasferirlo’ nel cordone ombelicale, che in alcune località viene conservato in un sacchetto e posto alle radici di un albero sacro. Questo rito, in qualche modo, era una sorta di proposta soprannaturale per preservare il neonato dalle malattie. Ancora. In caso di difficoltà nella fertilità, si impiegava lo yoloxóchitl, o flor del corazon, una sorta di antico Viagra che avrebbe la capacità di stimolare l’apparato cardiovascolare, con impatto anche sulla coppia.
In questo viaggio nel tempo e nelle culture, proviamo anche a dare uno sguardo al valore antropologico dell’alimentazione sulla fertilità e sulla natalità. “Nel mondo molte popolazioni dividono i cibi in due grandi gruppi, “caldi” e “freddi”, distinzione che non ha nulla a che vedere con la temperatura degli alimenti, ma è in rapporto con ancestrali credenze – segnala Guerci – Secondo quanto si sa della cultura messicana, determinate malattie o particolari stati come gravidanza, allattamento, problemi mestruali esigerebbero alimenti freddi come la carne, la farina di granoturco bianco, la zucca, la frutta, il formaggio, le patate. Sono invece considerati caldi le tortillas, il pane tostato, la farina d’avena, la cioccolata, il caffè nero, il latte, la carne di capra, il ghiaccio, i funghi selvatici”. Ma tra cibi caldi e cibi freddi non sempre esiste corrispondenza presso le varie popolazioni.
Se andiamo a vedere i costumi orientali, si possono studiare le diete dei monasteri del Tibet. “In questo caso la dicotomia non è tra caldo e freddo, ma tra Yin e Yang, cibi centripeti e cibi centrifughi – racconta Guerci – È centripeto, per esempio, ciò che penetra nella terra in senso verticale (ad esempio radici, tuberi, bulbi), mentre è centrifugo ciò che si eleva verso l’alto (come canna da zucchero, palma del cocco, frumento)”.
Anche l’architettura abitativa, infine, potrebbe giocare un ruolo sulla natalità influendo sul benessere della donna. “L’attenzione andrebbe prestata, in chiave antropologica, innanzitutto alla scelta del luogo, considerandone sicurezza, salubrità, vicinanza o lontananza dell’acqua – conclude Guerci – Altrettanto importante sarebbe, sulla scorta di convinzioni magiche e religiose, fare attenzione all’orientamento dell’abitazione, tenendo presente areazione, luminosità, convinzioni magiche e religiose. Senza dimenticare che in alcune culture c’era addirittura la tendenza a realizzare vere e proprie costruzioni speciali per le donne partorienti”. Insomma, se la scienza va avanti, la cultura e le tradizioni ci fanno volgere lo sguardo indietro. Perché proprio dalle tradizioni possiamo ancora imparare, in un mondo sempre più interculturale. Anche sul fronte della sfida della natalità.