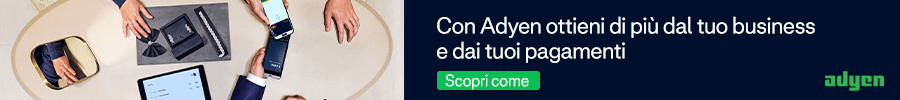Quando pensiamo alla malattia di Parkinson vengono subito in mente i tremori. Ma forse vi stupirà leggere che questo non è sintomo il più frequente, né il più insopportabile o imbarazzante per chi ne soffre. A dircelo è un’indagine realizzata su oltre 500 pazienti e caregiver italiani, che aiuta a far luce su una malattia neurodegenerativa in forte crescita, che colpisce più di 300mila connazionali.
Presentata in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia dalla Confederazione Parkinson Italia – con il supporto non condizionante di Zambon – l’indagine si accompagna a un documentario: “Dialoghi con Mr. Parkinson”, in cui tre pazienti, un clinico e una caregiver conversano con la malattia e ne svelano la complessità. L’11 aprile non è un giorno scelto a caso, ma la data di nascita di James Parkinson, che nel 1817 descrisse per la prima volta la malattia. Protagonista del documentario, però, non è il medico, paleontologo e geologo britannico, ma la “paralisi agitante” che a lui deve il nome, ovvero la personificazione della stessa malattia.
Oltre il tremore
Stando all’indagine, la maggioranza dei pazienti (79%) sapeva poco o nulla del Parkinson prima della diagnosi e non si aspettava questa molteplicità di sintomi (63%). Fra i più diffusi e pesanti: lentezza nei movimenti (72%), rigidità muscolare (62%), difficoltà nella scrittura (58%) e perdita di equilibrio (45%), ma anche disturbi del sonno (54%), problemi alla voce (50%), dolore (47%), stanchezza (46%) e ripercussioni sull’umore (44%).
Il Parkinson “ha un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle persone anche alla luce dei suoi numerosi sintomi – ricorda Paolo Calabresi, Ordinario di Neurologia dell’Università Cattolica – Una molteplicità di manifestazioni che richiede un approccio altrettanto plurale. È dunque importante aiutare le persone a coltivare momenti di socialità, a eseguire attività fisica leggera con le camminate aerobiche che hanno dimostrato effetti molto positivi sui pazienti e altri passatempi come la danza, l’attività teatrale, l’ascolto di musica e la pittura”.
Il futuro della ricerca
Ma dove sta andando la ricerca? “Guardare al futuro significa cercare di bloccare o rallentare il decorso di una malattia come il Parkinson”, ha spiegato Il professore ordinario di Neurologia Fabrizio Stocchi dell’IRCSS San Raffaele di Roma, nel corso di un incontro all’Ambasciata d’Austria dedicato alla malattia.
“Dagli anticorpi monoclonali che possono bloccare la proteina infettante, agli studi su pazienti con mutazioni genetiche causa della malattia, senza dimenticare la ricerca per rallentare i parkinsonismi come la paralisi sovranucleare progressiva o l’atrofia multisistemica”, ha precisato il neurologo.
Lo sguardo al futuro della diagnosi e della terapia non deve distogliere l’attenzione dai casi conclamati: “Nei pazienti in stato avanzato di malattia, dove le fluttuazioni motorie sono più frequenti, si possono usare farmaci che vengono infusi con device sottocute, come accade per i pazienti diabetici. Un approccio sintomatico molto efficace con una continuità d’effetto garantita”.
L’incontro a Roma ha avuto l’obiettivo di condividendo esperienze e prospettive future nella cura di una malattia che colpisce circa 30.000 persone in Austria e che rappresenta una delle principali sfide degli operatori impegnati in neurologia a livello globale. “L’Austria è riconosciuta a livello internazionale per il suo dinamico settore delle life sciences – ha ricordato Martin Eichtinger, Ambasciatore d’Austria presso la Repubblica Italiana – ed è un punto di riferimento nella biotecnologia e nelle scienze mediche, con numerosi centri di ricerca avanzata e collaborazioni internazionali in continua crescita”.
L’identikit dei pazienti
Quando si pensa al Parkinson, l’immagine più comune è quella di una malattia che colpisce per lo più gli anziani, ma i numeri raccontano un’altra storia. Secondo un’analisi del 2024 dei dati real world di IQVIA Italia, infatti, il numero di nuovi casi tra gli under 60 è in crescita, con un esordio che può verificarsi già a partire dai 40 anni. Nell’ultimo anno, sono state diagnosticate 16.000 persone che hanno iniziato il trattamento.
Il Parkinson sta entrando insomma nella vita delle persone in età lavorativa, influenzando la quotidianità, il lavoro e il benessere psicologico dei pazienti e delle loro famiglie.
Come cambia la terapia per il Parkinson
E le terapie? I farmaci a base di L-Dopa continuano a essere il pilastro del trattamento (40%), ma negli ultimi anni si è osservata una crescita nell’uso degli inibitori della monoamino ossidasi (MAOIs), passando dal 24% al 29%. Allo stesso tempo, gli agonisti della dopamina sono diminuiti significativamente, dal 25% al 18%.
Gli approcci, insomma, si stanno diversificando in base alle esigenze dei pazienti e alla progressione della malattia. Oltre alla L-Dopa, gli inibitori della MAO (come Rasagilina, Selegilina e Safinamide) stanno diventando sempre più importanti, mentre gli agonisti della dopamina (Apomorfina, Pramipexolo, Ropinirolo) vengono prescritti in modo più selettivo. Un altro dato interessante riguarda la diffusione degli inibitori della catecol-O-metiltransferasi (COMT), che rappresentano circa il 4% dei trattamenti, e gli anticolinergici vengono utilizzati nell’8% dei casi, soprattutto nei pazienti più giovani con sintomi predominanti di tremore.
Come succede sovente, però, la diffusione del trattamento non è omogenea in tutto il Paese. In questo caso Liguria, Abruzzo e Marche sono le regioni con la più alta concentrazione di pazienti in trattamento, mentre Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino mostrano numeri inferiori. “Questo divario è in parte legato alla distribuzione della popolazione anziana. L’accesso alla terapia può variare anche in base alle politiche sanitarie locali e alla disponibilità di farmaci e centri specialistici”, dicono da IQVIA.
Verso linee guida per Pdta sul Parkinson
Intanto qualcosa si muove. Con l’obiettivo di creare Linee di indirizzo nazionali per la definizione di Pdta su tutto il territorio italiano, la Confederazione Parkinson Italia ha annunciato a creazione di un tavolo di lavoro interdisciplinare che riunisce le associazioni di pazienti, l’Istituto Superiore di Sanità, la Limpe (Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento), la Società Italiana di Neurologia, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, la Società Italiana di Medicina Generale e oltre 30 professionisti sanitari coinvolti nel trattamento della patologia.
Il tavolo di lavoro avvierà un’indagine sui bisogni assistenziali delle persone con Parkinson in Italia. “Si tratta della patologia neurodegenerativa con i più alti tassi di crescita a livello mondiale e con una forte complessità di diagnosi e di gestione. Definire percorsi omogenei, integrati di cura e di assistenza – conclude Giangi Milesi, presidente Confederazione Parkinson Italia – è ormai prioritario e siamo così soddisfatti di aver promosso questo tavolo di lavoro nazionale. L’obiettivo è di dar vita a delle Linee di indirizzo per l’adozione di Pdta su tutto il territorio e compiere così un significativo passo in avanti verso un’assistenza più integrata, efficace ed incentrata sulla persona”. Per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Parkinson, il nuovo test che lo svela con 7 anni di anticipo