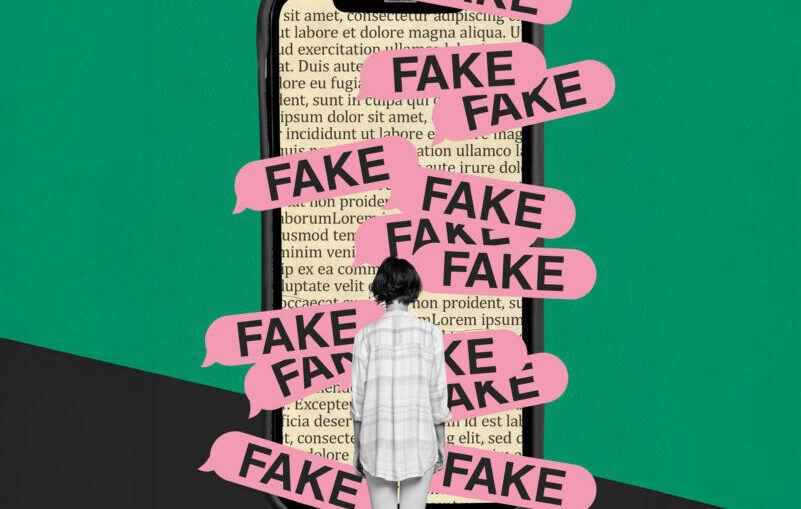Gli studi di Walter Quattrociocchi hanno spinto l’autrice della rubrica sulle fake news del Washington Post a chiuderla. Ma per il professore della Sapienza un antidoto alla disinformazione online è possibile.
C’è un momento preciso nel quale avete iniziato a sentire quasi ogni giorno il termine infodemia: il 2 febbraio 2020, la diffusione di informazioni false o fuorvianti relative al ‘nuovo Coronavirus’ stava diventando talmente allarmante che l’Oms incluse la sua preoccupazione sulla ‘infodemic’ nello stesso rapporto in cui aggiornava sull’evoluzione dell’epidemia.
Altrettanto precisa è la fonte accademica per la definizione dell’Oms di infodemia: un articolo, pubblicato sulla rivista Cell, firmato da un gruppo di studiosi coordinato dall’italiano Walter Quattrociocchi, oggi professore e presidente del corso di Data science e sistemi complessi della Sapienza, fondatore del Center of data science and complexity for society.
Confirmation bias, echo chamber, polarizzazione sui social media, disinformazione: leggere gli studi pubblicati da Quattrociocchi significa un po’guardarsi allo specchio. Capire come (e se) sia cambiata la nostra società. Il titolo del suo ultimo libro parla chiaro: ‘In che mondo vivi. Pillole di data science per comprendere la contemporaneità’.
Far lavorare insieme menti provenienti da tutto il mondo è uno degli aspetti più importanti del lavoro del professore. ‘Da tutto il mondo’ non è una locuzione casuale: al paper lavorarono, tra gli altri, Sylvie C. Briand (che ha guidato le iniziative su ebola e febbre gialla) e Lei Zhou, epidemiologo del Chinese Center for Disease Control and Prevention.
“La conoscenza è un esercizio collettivo”, spiega quando lo intervistiamo nel suo studio nel Dipartimento di informatica della Sapienza (coincidenza: è il palazzo accanto a quello dell’Istituto superiore di sanità, centro nevralgico della risposta italiana a Covid).
Alle spalle di Quattrociocchi, una lavagna illustra una ventina di studi. Quelli pubblicati, quelli in attesa di pubblicazione e quelli in lavorazione. Nella stanza accanto, in cui Quattrociocchi non ci porta, ci sono hard disk da 160 Tb di dati e “due piccoli supercomputer che ci siamo assemblati da soli” per analizzarli. Per costruire la sua macchina da data science Quattrociocchi ci ha messo diversi anni, nei quali ha accumulato oltre 20mila citazioni su Google Scholar e collaborato con Ocse, World economic forum e Governo inglese.
Questione di business
Tra i paper in lavorazione ce n’è uno sull’utilizzo delle inserzioni sui social. Piccolo spoiler: non sempre pagare significa avere più impression. Nel quarto trimestre 2024 Meta ha incassato 46,7 miliardi di dollari dall’advertising.
C’è poi uno studio che valuta la persistenza della disinformazione nel tempo e una ‘seconda puntata’ sulle echo platform. La prima, pubblicata nel 2024, riassume bene uno dei concetti che Quattrociocchi ripete da anni: i social sono pensati per l’intrattenimento, non l’informazione. È per alimentare l’intrattenimento che si incoraggiano gli utenti a interagire con chi la pensa come loro, amplificando la polarizzazione a tal punto che ormai si passa da una piattaforma all’altra in base a quelle più allineate con le proprie posizioni. Non più echo chamber all’interno dei social, quindi, ma intere piattaforme che “funzionano come nicchie ideologicamente omogenee”, ciascuna con la sua propensione alla disinformazione e all’uniformità di opinioni (in questo le piattaforme alt-tech di destra non si battono).
È sempre del 2024 lo studio pubblicato su Nature (‘Persistent interaction patterns across social media platforms and over time’) in cui le conversazioni tossiche dei social sono state analizzate su un arco temporale di 34 anni, su 8 social diversi: un totale di 500 milioni di commenti.
A caccia del comportamento umano
Un’analisi comparativa tra epoche diverse per andare a caccia del comportamento umano (ciò che rimane invariato nel tempo) e distinguerlo dall’influenza delle piattaforme. Il risultato? L’impatto dei social sui nostri comportamenti è “sopravvalutato”, dice Quattrociocchi.
“Le persone tendono a litigare sui social nel 2025 come facevano negli anni ’90” sugli antenati delle piattaforme di oggi, come Usenet. Inoltre non è vero che la tossicità è un deterrente al confronto online, anzi. Più una conversazione è lunga, più è probabile che diventi tossica. In tanti anni di ricerca Quattrociocchi ha scoperto che il dibattito su social e disinformazione si nutre, paradossalmente, di fake news e preconcetti infondati. Il professore si arrabbia quando si trova a dover discutere di sistemi complessi e AI con chi vede nella tecnologia una sorta di deus ex machina onnipotente e imperscrutabile, “come se le ‘allucinazioni’ di un’AI non fossero semplicemente dovute alla bontà della sua base dati”. Come se i meccanismi di disinformazione e polarizzazione che animano i social non fossero il ripetersi di un fenomeno umano in un ambiente creato e algoritmicamente perfezionato non per informare, ma per intrattenere.
Quando Mark Zuckerberg ha deciso di chiudere il meccanismo di fact checking delle sue piattaforme in molti si sono scandalizzati, preoccupati per le conseguenze sulla diffusione di contenuti ‘tossici’ su Facebook. Quattrociocchi ha ricordato come anni prima fosse stato già dimostrato che spesso il fact checking aveva l’effetto opposto a quello desiderato: “È stato registrato empiricamente che un utente, quando viene avvisato della scarsa veridicità di una notizia, tende a seguirne la fonte con ancora maggiore convinzione”, spiega il professore.
L’antidoto alla disinformazione
Se allora neanche il fact checking può funzionare, qual è l’antidoto alla disinformazione online? Quattrociocchi mostra con orgoglio la mail con cui è stato chiamato a collaborare dal Governo inglese sulla prevenzione della disinformazione nella campagna vaccinale anti-Covid. Una mail arrivata dopo la pubblicazione dell’articolo sull’infodemia, in cui ha dimostrato come in realtà la diffusione delle informazioni false non abbia niente di virale, confutando la presunta capacità delle notizie false di diffondersi più velocemente di quelle vere. “Le informazioni, su quelle macchine da intrattenimento che sono i social, si diffondono in base al pubblico che incontrano” e, insiste Quattrociocchi, “al meccanismo delle echo chamber”.
La spiegazione migliore l’ha forse data Caitlin Dewey, che ormai dieci anni fa ha chiuso una sua famosa ‘column’ sulla disinformazione sul Washington Post (‘What was fake this week’) proprio dopo aver letto uno studio di Quattrociocchi, che all’epoca lavorava all’Imt di Lucca.
“Solitamente questo spazio è dedicato a smentire le bugie, le bufale e le teorie del complotto che giorno dopo giorno girano su internet. Questa settimana non posso farlo. Mi devo astenere: c’è uno studio che dice che ogni tentativo di debunking è, per dirla in breve, inutile”.
Disinformazione, che senso ha combattere le bufale?
Che senso aveva una rubrica sul debunking se le stesse persone che avrebbe dovuto raggiungere erano ostinatamente chiuse nelle loro camere d’eco, in quel caso piene di teorie del complotto e teorie no-vax? Ma Quattrociocchi pensa che le porte di quelle ‘chamber’ (oggi ‘platform’) si possano ancora scardinare, “mostrando alle persone quali meccanismi governino la diffusione delle informazioni (vere e false) online”. E spiegare che quei meccanismi, ben sfruttati da chi trae profitto dal nostro intrattenimento, sono radicati in noi, non in un algoritmo. Questo vuol dire che le piattaforme non hanno responsabilità?
Tra i paper preferiti di Quattrociocchi ce ne è uno firmato dal sociologo Duncan J. Watts sui falsi miti della disinformazione, che illustra il gap tra ricerca scientifica e dibattito pubblico e che chiede ai social una maggiore trasparenza: “Raccomandiamo di ritenere le piattaforme responsabili per aver facilitato l’esposizione a contenuti falsi ed estremi”. Gli esseri umani sono rimasti gli stessi di 34 anni fa, è vero. Ma il mondo in cui vivono è sicuramente cambiato.
L’articolo originale è stato pubblicato sul numero di Fortune Italia dell’aprile 2025 (numero 3, anno 8)