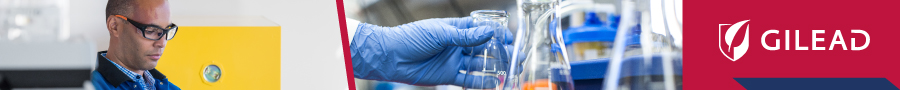Negli ultimi anni molte aziende che avevano delocalizzato la loro produzione in Paesi lontani stanno facendo dietro-front per riportarle del tutto, o in parte, a casa. Il fenomeno si chiama reshoring e sta diventando una dinamica sempre più consistente e dibattuta all’interno dei consigli di amministrazione delle grandi società occidentali.
“Il reshoring è sostanzialmente quel fenomeno per cui delle attività della catena del valore dell’impresa da una localizzazione estera vengono riportate nel Paese di origine”, ci spiega Antonio Majocchi, ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Luiss Guido Carli di Roma. “È un po’ come se fosse una sorta di marcia indietro rispetto all’internazionalizzazione nel senso che si decide prima di andare in altri Paesi perché ritenuti più convenienti e poi ci si rende conto che in realtà, con il protrarsi del tempo, la scelta effettuata si è rivelata sbagliata o, a causa delle nuove condizioni di mercato, non più vantaggiosa”.
Prima la pandemia, ora la guerra in Ucraina. Il rientro delle aziende è dettato da semplici fattori economici?
No, ad incidere sulla decisione non ci sono solo fattori economici e un differenziale di costi ma anche di rischio geopolitico e di sicurezza degli approvvigionamenti. Molte aziende europee che prima avevano fornitori che producevano in giro per il mondo adesso preferiscono optare per quelli che sono più vicini. Qui stiamo parlando di rapporti di mercato, dunque, non di catene del valore. E poi ci sono le tensioni geopolitiche tra gli Stati che rendono più difficili alcuni legami economici, per cui alcune aziende, per esempio americane, preferiscono tornare negli Stati Uniti perché avere la produzione in Cina potrebbe essere rischioso. Un problema molto sentito ormai anche dalle società europee.
Dunque, in questi anni si è creata anche la necessità di una rielaborazione della supply chain locale?
Il fenomeno generale era già presente ma il Coronavirus prima e la guerra in Ucraina dopo l’hanno mostrato chiaramente: le imprese stanno ripensando alle loro catene del valore ristrutturandole a livello mondiale e, in questo ambito, c’è una forte tendenza verso la regionalizzazione. Le imprese americane preferiscono riportarle negli Stati Uniti ma anche in luoghi vicini come, ad esempio, in Messico.
Anche le aziende europee hanno una propensione a riavvicinare la produzione nel vecchio continente e questo comporta poi che avvenga all’interno dell’Europa stessa una riorganizzazione. Quindi siamo nel mezzo di un’evoluzione del processo produttivo, molto differente da quello che conoscevamo.
Anticipava che questo è un fenomeno che sta nascendo adesso. Quali sono le sue dimensioni?
È un fenomeno che non è stato misurato ancora e per cui è difficile dare dei numeri precisi. Lo European Reshoring Monitor, il centro studi della Commissione europea nel quale ci sono dentro anche molte università italiane, ha fatto una prima ricerca e ha analizzato centinaia di imprese europee. L’entità del fenomeno non è semplice da evidenziare perché è difficile sapere quante informazioni vengano chiuse all’interno delle società e quanto dei nuovi investimenti fatti da queste imprese facciano parte del fenomeno di reshoring o siano parte dell’aumento della loro produzione, ma stiamo parlando comunque ormai di un evento consistente che riguarda tante società del nostro continente.
Avere siti produttivi in Italia o in area Euro rispetto ad averli al di fuori dei confini europei può essere vantaggio competitivo nel medio periodo?
Beh, sicuramente il primo vantaggio è il fatto che si crea una stabilità della catena di produzione. Il secondo è ricollegato alla convenienza economica di produrre in Cina che, negli anni, per via degli aumenti del costo del lavoro e dei trasporti, è diminuita. Un aspetto che si è rivelato presto un problema a livello internazionale, anche se negli ultimi mesi il vantaggio economico in Europa, e in Italia in modo particolare, si è leggermente ridotto a causa del costo dell’energia. Però questi fenomeni vanno visti nel medio e lungo termine e sicuramente questo evento potrebbe migliorare la qualità della produzione, in generale, per le imprese del nostro Paese. Ma la sua riuscita dipenderà molto anche dalle caratteristiche strutturali dell’economia italiana che dovrà investire in ricerca e sviluppo e in tutti quegli aspetti che rendono la produzione più competitiva.
E che cosa dovrebbe fare secondo lei l’Italia per essere pronta ad affrontarlo?
Noi siamo nel mezzo di numerose trasformazioni, tra cui quella ecologica e quella digitale, e sono tutte trasformazioni che richiedono nuovi modelli di produzione ma anche un forte investimento sulle conoscenze. La volontà americana di cercare di favorire il fenomeno della rilocalizzazione in parte sta diventando anche europea. Ma questa è, secondo me, una politica di breve termine. Nel medio e lungo periodo la risposta a questi grandi fenomeni dovrebbe essere data soprattutto da una politica industriale comunitaria perché se parliamo, ad esempio, della riconversione, le cifre sono talmente ampie che nessun Paese europeo da solo le può sostenere. Gli europei, rispetto ad americani e cinesi, sono indietro su questo aspetto e stanno cercando di recuperare rapidamente. Invece sotto il profilo italiano abbiamo un enorme patrimonio ma per valorizzarlo dobbiamo investire in formazione, ricerca e competenze tecniche.
Come fare a valorizzare queste aziende che riassorbono risorse dentro i territori?
Ogni volta che c’è una forte deconversione tecnologica ci sono dei vincenti e dei perdenti e due tipi di approccio. Il primo è un approccio di mitigazione degli impatti sociali. Guardiamo cosa sta succedendo al mercato dell’auto. Che si vada verso una riconversione ecologica è certo e che questo comporterà una trasformazione molto significativa del settore anche. I fornitori delle più grandi case automobilistiche diminuiranno drasticamente e tra questi alcuni saranno vincenti, altri perdenti. È un problema sociale e non economico. Dall’altro lato, inoltre, secondo me bisogna favorire questo processo, cercare di rallentarlo è sbagliato pur sapendo che comporterà grossi costi. Ci vogliono dei programmi europei che favoriscano la nascita di grandi imprese comunitarie che potranno poi diventare i futuri fornitori su cui le piccole e medie imprese potranno costruire il loro successo. Le società italiane nel nuovo contesto internazionale, se adeguatamente aiutate, potrebbero essere veramente molto competitive.
Quali sono i settori che stanno facendo maggiormente reshoring e in quali Paesi stanno tornando?
Sono diversi. In Europa il fenomeno riguarda soprattutto Francia, Germania, parte dell’Inghilterra e l’Italia. Quindi i grandi Paesi industrializzati.
Anche gli Stati Uniti fanno sia reshoring sia backshoring e nearshoring. Cioè riportano, magari in Paesi vicini come il Messico, la produzione. Per quanto riguarda i settori, invece, in Italia la diffusione è abbastanza trasversale anche se colpisce soprattutto quei comparti che più significativamente avevano fatto delocalizzazione delle attività produttive, come il tessile e la meccanica. Meno il mondo dell’arredamento, perché queste aziende hanno preferito concentrarsi sulla qualità italiana e quindi per loro era importante restare nel nostro Paese.
L’ultima domanda un po’ me l’ha anticipata, l’inizio del Reshoring è la fine della globalizzazione?
Me lo chiedo anch’io spesso, se sia alla fine della globalizzazione. Non riesco a dare una risposta esatta perché non sono in grado di dirlo. Diciamo che io penso sia un processo di progressiva regionalizzazione. Ormai la scala della produzione non è più nazionale. Nessuna azienda, piccola media o grande che sia, oggi può pensare di lavorare solo su scala nazionale, soprattutto le imprese italiane che hanno tassi di esportazione molto rilevanti. Quindi se lei mi chiede se sia la fine dell’internazionalizzazione generale, io penso di no, ma è evidente che sta avvenendo una grossissima riconfigurazione a livello mondiale e soprattutto a livello regionale, nel senso delle grandi regioni come il Nord America, l’Europa e il Sud-Est asiatico. La globalizzazione come l’abbiamo conosciuta non credo finirà perché ci sono alcuni aspetti che sono ormai strutturati, ma credo che sia in atto una ristrutturazione delle catene del valore e quindi una nuova organizzazione della produzione mondiale. Naturalmente poi dipenderà moltissimo dagli aspetti politici che sono quelli fondamentali perché è chiaro che più le tensioni internazionali crescono, più il fenomeno della globalizzazione farà fatica a mantenersi. Questo è veramente un grandissimo punto interrogativo.