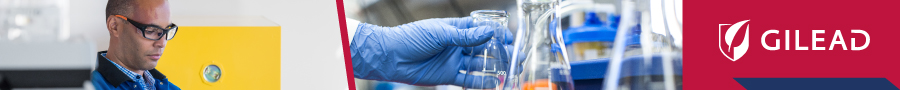Viviamo un’epoca sovraffollata di segni e messaggi. Ogni giorno decodifichiamo una massa impressionante di pittogrammi e simboli e leggiamo l’equivalente di 34 gigabyte di testi (pari a un intero romanzo).
I marchi registrati nel mondo hanno superato i cinquanta milioni, senza contare la mole infinita di quelli non coperti da brevetto. Spendiamo una parte importante del nostro tempo (e anche dei nostri soldi) in uno spazio immateriale, oltre quello fisico che ci ospita realmente, in una condizione di illusoria ubiquità…
Tutto questo ha moltiplicato in maniera iperbolica il numero delle interazioni, modificando di conseguenza i comportamenti: nella virtualità della relazione, si è acuita la frattura tra l’essere e l’apparire, dando vita a vere e proprie messe in scena, che sembrano trasformare il mondo in un infinito teatro, dove tutti siamo attori e spettatori al tempo stesso.
È come se, d’un tratto, gli esseri umani avessero deciso di trasformarsi in brand, evocando mondi possibili, di cui sono essi stessi simbolo. La domanda viene perciò spontanea: se tutto diventa brand, cosa diventa il brand? La risposta va cercata dentro l’intricato binomio realtà-rappresentazione, che ha fatto la sua comparsa sulla terra insieme ai nostri più lontani antenati.
Da sempre, infatti, abbiamo preferito dare espressione più alle nostre aspirazioni che misurarci con la crudezza della realtà. La dimensione simbolica è di conseguenza parte fondamentale del nostro modo d’essere ed è agevole rileggere attraverso questo filtro l’intera storia dell’umanità.
Dalle piramidi ai templi greci, passando per le grandi infrastrutture romane, per le cattedrali medievali, per lo splendore delle architetture rinascimentali e per l’opulenza di quelle barocche, fino alle realizzazioni delle archistar contemporanee, gli esseri umani hanno sempre eretto monumenti a se stessi, dando rappresentazione al proprio esistere e governando in questo modo la relazione con le diverse categorie di pubblico. Sarebbe tuttavia riduttivo considerare come degne di valore simbolico solo le grandi realizzazioni architettoniche e artistiche.
L’attribuzione di significati diversi da quelli meramente funzionali o razionali, assegnati alle “cose”, risale anch’essa alle origini del mondo. Ma è con l’avvento della prima rivoluzione industriale che si manifesta un fenomeno che porterà progressivamente alla trasformazione delle merci (o di alcune, in particolare) in simboli: l’origine di ciò che ora chiamiamo brand.
I contadini, che avevano abbandonato le campagne per trasferirsi nelle città, dove erano diventati operai, avevano progressivamente perso il rapporto con i prodotti della terra e, al baratto, avevano sostituito l’acquisto. Così, il nome di un produttore, che garantiva nel tempo una migliore qualità e/o un prezzo più equo rispetto alla concorrenza, diventava una consuetudine nella spesa e, progressivamente, veniva indicato al posto dello stesso prodotto.
Una metonimia che sanciva l’affermazione del marchio, inteso come memoria del prodotto. La priorità era comunque tutta nell’etichetta, che assegnava al brand una funzione esclusivamente segnaletica: distinguere cioè un prodotto da un altro. Sul piano della rappresentazione visiva, si faceva ricorso generalmente a decorazioni delle lettere che componevano il nome.
Più tardi, nella seconda metà del XIX secolo e nei primi decenni del XX, il design del marchio sì manifestò spesso importando dall’araldica riferimenti a motivi floreali, ad animali nobili o leggendari. La progressiva notorietà si tradusse cioè in una sorta di aristocrazia che, alla pari di quella degli umani, si dotava di un proprio blasone. Questo inedito status decretò il sorgere dei primi “corporate brand”, quale naturale estensione dell’etichetta, dalle merci all’impresa, stante l’associazione logica tra il nome del prodotto (o della gamma) e quello del produttore.
Un’affermazione che, dalla seconda metà dell’800, trovò nella regolamentazione giuridica il miglior riconoscimento: il brand, insomma, aveva vinto la sua scommessa con la storia. Naturalmente, la funzione era e restava segnaletica, non possedendo ancora alcun valore intangibile, ma in grado in ogni caso di orientare il consumatore, grazie alla notorietà della merce offerta, e di liberare l’impresa produttrice dalla subalternità nei confronti dei grossisti. Questo salto culturale trovò un consolidamento nei primi decenni del ‘900 perché la saldatura tra avanguardie artistiche e industria fu all’origine di associazioni dall’impatto straordinario.
Un esempio per tutti è la produzione di Depero per Campari, per citare un caso italiano tra i più noti. Sarebbe tuttavia sufficiente ricordare l’esperienza della Bauhaus (la scuola fondata da Walter Gropius a Weimar, in Germania, nel 1919) per cogliere il senso di un cambiamento epocale, i cui effetti, anche nell’ambito del brand design, sono ancora di straordinaria attualità. Occorrerà attendere gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso per assistere a un’ulteriore affermazione del brand: la sua funzione segnaletica si arricchisce, diventando garanzia. Un successo propiziato dall’azione integrata di due fondamentali alleati: la televisione e la Grande Distribuzione Organizzata.
I brand fanno ormai parte del paesaggio – reale e immaginario – delle società più avanzate. La loro notorietà costituisce un punto di riferimento certo per il consumatore che, posto di fronte a una scelta tra un prodotto e un altro, si sente gratificato e garantito (appunto) da quello più noto. Questo spiega l’attenzione alla “brand image” (espressione coniata nel 1955) come sistematizzazione del marchio: l’etichetta, fino ad allora applicata praticamente al prodotto e poi all’impresa, viene estesa in maniera coerente ad ambiti anche molto eterogenei tra loro, come la modulistica, le insegne e la segnaletica, le livree dei mezzi di trasporto, le uniformi per il personale e, naturalmente, le confezioni, la pubblicità, le promozioni…
Un quadro idilliaco che si infrange però negli anni ’70, quando, per effetto dello shock petrolifero, l’aumento del costo delle materie prime determina una forte contrazione nelle vendite in tutti i paesi sviluppati e in tutti i settori commerciali, compresi i beni di largo consumo.
La risposta dei grandi gruppi si tradusse in una proliferazione di marchi, strumentali a segmentare i vari pubblici – con differenti livelli di prezzo – per mantenere inalterate le rispettive quote di mercato.
Il branding conobbe di conseguenza una vera e propria impennata quantitativa, anche se i numeri, confrontati con quelli dei decenni successivi, erano comunque bassi. Questo nuovo quadro dimostrò che l’efficacia del brand non si limitava più ai prodotti di largo consumo ma poteva essere estesa ai beni durevoli, ai servizi, alle imprese, ai gruppi industriali, fino ai territori e alle stesse istituzioni.
Si era consolidata quindi la frattura tra mondo “branded” e mondo “unbranded”: poiché è branded tutto ciò che non ha bisogno di essere spiegato, si apre la corsa alla conquista del marchio. E i prodotti unbranded sono condannati a un destino da commodity, il cui valore economico è legato esclusivamente al rapporto prezzo/quantità.
Cambia nuovamente lo stesso paradigma di brand: non era più l’elemento da associare a prodotti, servizi e imprese per facilitarne la riconoscibilità e quindi la preferenza, ma il riferimento a una relazione (non più e non solo segnaletica e di garanzia) in grado di dare rappresentazione a un universo di cui il cliente vuole sentirsi parte.
Questa dimensione relazionale del brand segnò nei fatti il passaggio dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa, esaltando da un lato il valore intangibile del brand e dall’altro rafforzando sempre più il rapporto tra questo e il singolo stakeholder. Restarono tuttavia inalterate le logiche proprie dell’etichetta/marca da iterare su un numero imprecisato di touchpoint.
Ma, a rompere i nuovi equilibri, è la rivoluzione compiuta nell’ultimo decennio del secolo scorso da telefonia mobile e internet. Con la loro convergenza, tutti i criteri tradizionali entrano in crisi o si modificano in maniera tanto inedita quanto decisa: il concetto stesso di comunicazione di massa perde significativamente ruolo perché, al messaggio da uno a molti, si affianca una modalità che premia la relazione da uno a uno o da molti a molti.
La dematerializzazione che si manifesta con l’avvento del digitale produce effetti con cui l’intera umanità si sta ancora misurando. Cambiano le stesse nozioni di tempo e spazio e si va delineando di conseguenza anche quella di brand contemporaneo.
Il mondo analogico si fondava sulla produzione di oggetti concreti, che si proponevano attraverso logiche di qualità e prezzo. Quello digitale è invece incardinato sulla produzione di servizi che determinano esperienze in chi li utilizza. Poiché il miglior sinonimo di servizio è relazione, il passaggio che si è verificato – come sostiene il filosofo Luciano Floridi – è appunto dalle “cose” alle “relazioni”. Un nuovo cambio di paradigma in cui la centralità del prodotto è stata sostituita da quella della persona che, vivendo l’esperienza, integra in se stessa tutti gli aspetti – materiali e immateriali – insiti nella fruizione. Perché, una volta realizzata, l’esperienza appartiene a chi l’ha vissuta, è cioè un patrimonio immateriale che entra a far parte della sua storia personale. Il prodotto, in questo quadro, assume ruolo e importanza solo se è in grado di generare appunto esperienza.
Trovano perciò rilievo tutti gli aspetti non funzionali, come la dimensione estetica, quella emotiva, quella del racconto ecc. Questa interazione posta in essere dal digitale nel dialogo tra brand e consumatore, in cui quest’ultimo svolge un ruolo attivo, determina il superamento del concetto stesso di etichetta, associato al brand. Questo non è più effetto di un prodotto, servizio ecc., ma causa che, guidando la relazione con la propria comunità di stakeholder, propone prodotti, servizi etc.
Da qui, anche la cosiddetta “centralità” del cliente, che è il risultato più evidente dell’affermazione del digitale. Si è al centro del navigatore e la percezione dello spostamento è dato dallo scorrere della mappa in senso contrario alla direzione di marcia… ma si è al centro di tutte le scelte che ogni device rende possibili con incredibile facilità: programmare un viaggio, trovare la casa da comprare o quella in cui trascorrere una vacanza, scovare oggetti impossibili, farsi portare il cibo, abbonarsi a un giornale o a un canale televisivo… è sufficiente disporre di una carta di credito in efficienza e il mondo (è il caso di dire) arriva a destinazione.
Allora cosa è diventato il brand? È sempre più l’espressione di un’identità in divenire, che ha abbandonato la sua statica dimensione simbolica per trasformarsi in un hub narrativo.
Ai fini dello storytelling, infatti, la funzione esercitata dal brand diventa analoga a quella delle ‘location’ delle varie serie televisive, dove un ospedale, una stazione di polizia, per fare degli esempi facili, diventano il palcoscenico su cui si rappresentano le vite dei protagonisti e dei comprimari. Il brand è la cornice in grado di ospitare e valorizzare più storie, unite dalla coerenza della proposizione, che è effetto dell’integrazione di diversi tipi di design.
In conclusione, siamo diventati tutti brand? Quello delle origini serviva a distinguere un prodotto da un altro; quello contemporaneo distingue un cliente da un altro. Come dire che, nel passaggio dalla centralità del prodotto a quella della persona, noi abbiamo preso appunto il posto dei prodotti…
*Antonio Romano, 67 anni, pugliese, è laureato in Architettura. Ha fondato Inarea, un network indipendente, che opera nell’ambito dei sistemi di identità per imprese, istituzioni, prodotti e servizi. È considerato uno dei massimi rappresentanti italiani del brand design e la società da lui fondata e diretta è leader nel campo del corporate brand. Ha tenuto corsi e seminari in varie università (Bocconi, Cattolica, Harvard, IULM, Luiss, Sapienza, Universidade de Vigo) ed è docente alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. È stato insignito del Pantone Prize ed è Brand Ambassador dell’International Trademark Center. Mostre dedicate alla sua attività si sono tenute a New York, Buenos Aires, Bruxelles, Varsavia, Berlino, Copenaghen, Roma e Milano.